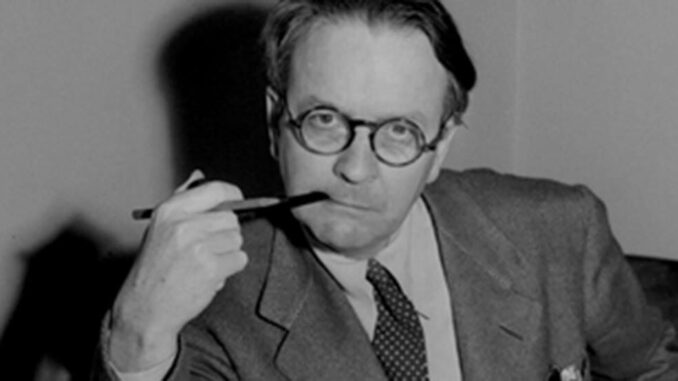
LIBRI Una delle ragioni per leggere Raymond Chandler, questa estate e ogni estate, forse è proprio la calura estiva, presente e concreta in molte pagine dello scrittore americano morto a 71 anni nel 1959. Per esempio in questa descrizione di una strada di Pasadena, in California (la città dove quasi vincemmo il mondiale di calcio del 1994): «Un intenso profumo d’estate impregnava la mattinata, e tutto ciò che cresceva era perfettamente immobile nell’aria greve che si respira da quelle parti in certe giornate considerate belle e fresche da chi ci abita». Citiamo da Finestra sul vuoto (1942), dalla nuova versione, appena comparsa, di Gianni Pannofino, che dal 2019 sta ritraducendo per Adelphi, in ordine sparso, i romanzi di Chandler con protagonista l’investigatore privato Philip Marlowe.
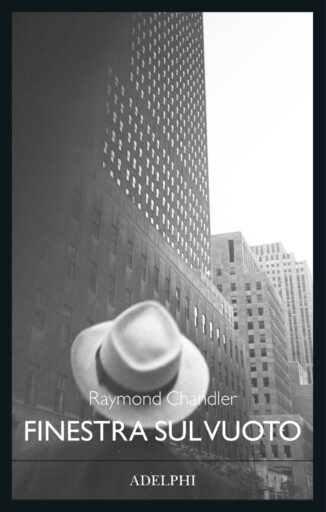 Finora ne sono usciti quattro (su sette), che vanno curiosamente a piazzarsi a fianco dei due «Meridiani» Mondadori del 2006, che già ritraducevano le gloriose (per noi) versioni di Oreste Del Buono e Ida Omboni e Giuseppe Trevisani, che a loro volta… Questa sequela per dire che Chandler è un autore familiare ai lettori italiani da oltre 70 anni; e che il passaggio dagli smilzi Gialli Mondadori del primo Dopoguerra al piano attico di Adelphi riflette quanto lui stesso sperimentò (e dibatté) nella sua vita: che l’automatica, moralistica ripartizione della letteratura «di genere» o «d’evasione» era frutto di una visione esterna e pregiudiziale.
Finora ne sono usciti quattro (su sette), che vanno curiosamente a piazzarsi a fianco dei due «Meridiani» Mondadori del 2006, che già ritraducevano le gloriose (per noi) versioni di Oreste Del Buono e Ida Omboni e Giuseppe Trevisani, che a loro volta… Questa sequela per dire che Chandler è un autore familiare ai lettori italiani da oltre 70 anni; e che il passaggio dagli smilzi Gialli Mondadori del primo Dopoguerra al piano attico di Adelphi riflette quanto lui stesso sperimentò (e dibatté) nella sua vita: che l’automatica, moralistica ripartizione della letteratura «di genere» o «d’evasione» era frutto di una visione esterna e pregiudiziale.
Tra i tanti suoi commenti, c’è questo, semplicissimo: «Tutto quel che si legge per piacere è un’evasione, si tratti di greco, di matematica o d’astronomia, di Benedetto Croce o delle memorie di un uomo qualunque. Affermare il contrario significa essere uno snob intellettuale e un principiante nell’arte di vivere».
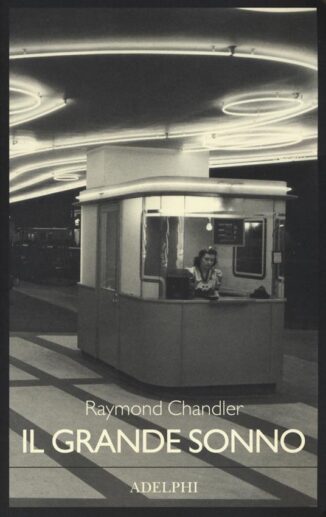 Nel 1939, nel romanzo Il grande sonno, Chandler aveva fatto debuttare il «segugio» Philip Marlowe di Los Angeles, diventato il capostipite (la parola archetipo rischia lo snobismo intellettuale) di una genealogia fattasi sterminata molto spesso per mero tentativo di replicazione. Onesto perciò povero, sentimentale e pietoso (sotto uno schermo di cinismo), colto senza obbligo, puro e dolente in mezzo allo squallore della ricchezza mal guadagnata e di ogni forma di corruzione… Marlowe (improbabile? fiabesco?) è un fallito, nella società del profitto e dello spettacolo, e sa di esserlo: ciò nonostante, continua a voler restare in piedi, a difendere, da solo, un nucleo essenziale di decoro, da alimentare sotto pesanti braci: «Uscii nell’aria della notte, sulla quale nessuno finora è riuscito a far valere un diritto di prelazione. Ma chissà quanti stan tentando l’impossibile. E un giorno o l’altro ci arriveranno» (La sorellina, 1949).
Nel 1939, nel romanzo Il grande sonno, Chandler aveva fatto debuttare il «segugio» Philip Marlowe di Los Angeles, diventato il capostipite (la parola archetipo rischia lo snobismo intellettuale) di una genealogia fattasi sterminata molto spesso per mero tentativo di replicazione. Onesto perciò povero, sentimentale e pietoso (sotto uno schermo di cinismo), colto senza obbligo, puro e dolente in mezzo allo squallore della ricchezza mal guadagnata e di ogni forma di corruzione… Marlowe (improbabile? fiabesco?) è un fallito, nella società del profitto e dello spettacolo, e sa di esserlo: ciò nonostante, continua a voler restare in piedi, a difendere, da solo, un nucleo essenziale di decoro, da alimentare sotto pesanti braci: «Uscii nell’aria della notte, sulla quale nessuno finora è riuscito a far valere un diritto di prelazione. Ma chissà quanti stan tentando l’impossibile. E un giorno o l’altro ci arriveranno» (La sorellina, 1949).
Marlowe racconta in prima persona, e il suo monologo, foggia del suo carattere, è un modello (imitatissimo) di stile. Chandler lo si può leggere anche solo per questo motivo: lo stile, e la capacità superba, abbagliante, di vedere e far sentire le cose per similitudini (come il poeta che avrebbe voluto essere, e che è riuscito a essere in questa forma). Si può scegliere quasi ad apertura di pagina.
Lo facciamo: «Ripassai sotto l’arco e m’incamminai per le scale. Per gli appassionati di alpinismo sarebbe stata una bella passeggiata. Fino a Cabrillo Street erano duecentottanta scalini, cosparsi di sabbia portata dal vento. La ringhiera, fredda e umida, rassomigliava alla pancia di un rospo» (Addio mia amata, 1940). Del resto, Chandler scelse il nome del suo eroe pescando tra i poeti inglesi della sua educazione. E si prese il gusto (per autodifesa un po’ snob) di mettergli in bocca citazioni da antologia, come questa: «L’ora, il luogo e l’essere amato non si trovano mai insieme». A chi gli chiede «Che roba è?», Marlowe risponde: «Browning. Il poeta, non l’automatica. Sono certo che voi preferireste l’automatica».
Edoardo Borra

