
di Alice Ferrero
ALBA – C’è un momento speciale, nei giochi dei bambini, in cui le regole smettono di essere istruzioni e diventano ponti: collegamenti tra mondi, linguaggi e possibilità diverse. È in questo spazio di incontro che nasce Strega Tocca Colore, il nuovo libro di Sabrina Costa, educatrice albese che da anni lavora nel campo della riabilitazione e dell’inclusione scolastica.
Con la curiosità di chi osserva ogni dettaglio e la passione di chi crede nella forza delle relazioni, Costa trasforma il gioco in un linguaggio universale, fatto di simboli, immagini e regole condivise.
Il volume, ispirato ai principi della comunicazione aumentativa e alternativa (Caa), raccoglie giochi della tradizione — da Nascondino a 1, 2, 3 Stella, fino a Strega tocca colore — reinterpretandoli come strumenti inclusivi, capaci di accogliere ogni bambino nel cerchio del gioco, senza lasciare nessuno indietro. Un’idea semplice e insieme rivoluzionaria: partire dal divertimento per costruire comprensione, empatia e partecipazione.
Attraverso le sue pagine, l’autrice invita educatori, insegnanti, genitori (e anche nonni) a riscoprire il valore educativo del “mettersi in gioco” in senso pieno: perché giocare insieme significa imparare a rispettare i turni, accettare la frustrazione della sconfitta, gioire delle vittorie altrui. Significa imparare a comunicare, ancora prima che a parlare.
Simboli che diventano parole
In questa intervista, Sabrina Costa ci accompagna nel suo modo di intendere l’educazione: un viaggio fatto di simboli che diventano parole, di gesti che si trasformano in dialogo, di sguardi che raccontano più di mille frasi. Un invito a ripensare la comunicazione come uno spazio comune, dove la diversità non è un limite ma una risorsa, e dove ogni bambino può trovare — nel gioco — il proprio posto, la propria voce e la propria gioia di esserci.
Nel libro il gioco diventa un linguaggio. Quando ha capito che poteva essere uno strumento di comunicazione efficace anche per i bambini con difficoltà comunicative? C’è stato un episodio chiave nel percorso professionale?
«Il gioco è per sua natura un linguaggio universale, attraverso il quale i bambini esplorano, esprimono emozioni, imparano e crescono. Questo vale per tutti, ma in presenza di difficoltà comunicative può diventare un’esperienza complessa: capire e condividere regole, tempi e modalità può rivelarsi una sfida. Chi lavora con i bambini lo sa: servono strumenti concreti che facilitino davvero la relazione e permettano a ciascuno di partecipare. Da qui nasce il mio desiderio di creare strumenti che rendano il gioco un’esperienza accessibile e inclusiva per tutti».
Ha scelto giochi della tradizione e li hai “tradotti” usando la comunicazione aumentativa e alternativa . Quali principi pedagogici e comunicativi hanno guidato nella selezione e nell’adattamento delle attività?
«La scelta dei giochi nasce dall’esperienza diretta con i bambini. I giochi della tradizione non tramontano mai e conservano una magia che attraversa le generazioni: Nascondino, 1, 2, 3 Stella o Strega tocca colore fanno ancora ridere, correre, stare insieme. Sono spazi di relazione dove un bambino che comprende le regole può sentirsi parte del gruppo. L’adattamento in Caa serve a rendere queste esperienze più chiare e accessibili a tutti. È un processo in continua evoluzione, che nasce dall’incontro quotidiano con i bambini e le loro modalità comunicative. Un bambino che capisce meglio le regole può giocare, e quindi comunicare: è uno dei principi cardine della Caa, che mette al centro la persona e il suo diritto di esprimersi».
La comunicazione aumentativa e alternativa è spesso considerata un supporto tecnico. Nel tuo lavoro diventa invece un ponte relazionale. Come si costruisce questa connessione attraverso simboli e immagini?
«La Caa non è soltanto uno strumento tecnico: è, prima di tutto, una forma di relazione. Mette al centro la persona, i suoi bisogni comunicativi e le sue possibilità, con l’obiettivo di favorire autonomia e partecipazione. Simboli, immagini, gesti o dispositivi elettronici diventano linguaggi condivisi, che permettono di raccontarsi anche quando le parole non bastano. Non si tratta di sostituire il linguaggio verbale, ma di ampliarlo. La relazione nasce proprio da questa apertura: usare strumenti che non semplificano soltanto, ma che rendono possibile un dialogo autentico».
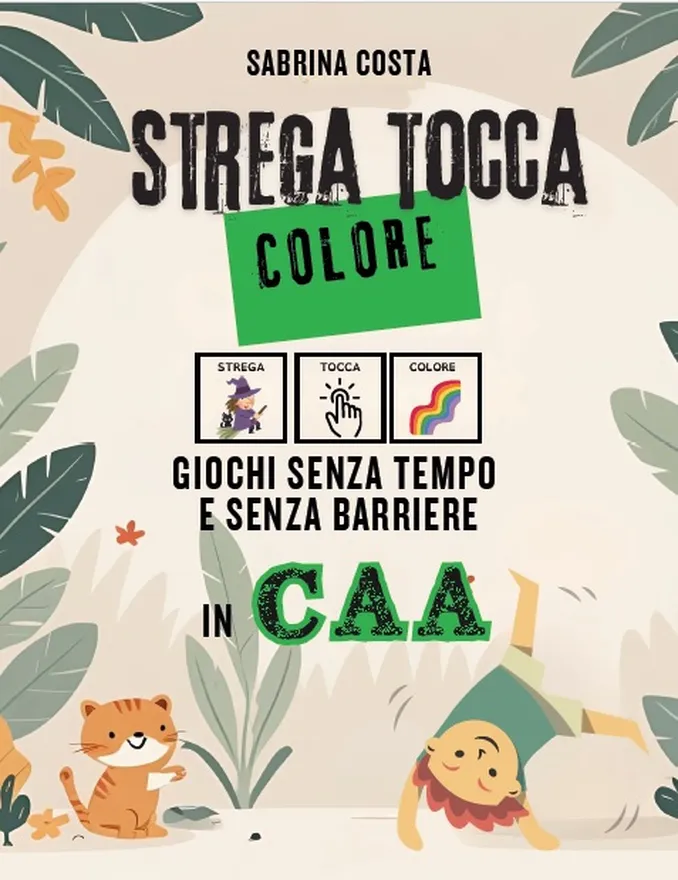
Nel libro dai grande importanza alla gestione del turno, alla vittoria e alla sconfitta. Perché partire da questi aspetti e che ruolo hanno nello sviluppo dell’identità del bambino?
«Turni, vittoria e sconfitta sono le fondamenta del gioco, spesso date per scontate ma non facili da comprendere. Riguardano non solo la dinamica ludica, ma anche il rispetto dell’altro, la gestione dell’attesa, la frustrazione e la consapevolezza di sé. Imparare ad aspettare il proprio turno o ad accettare di perdere significa imparare a stare nella relazione, a gestire emozioni intense e a riconoscersi dentro un gruppo. Il gioco è uno spazio dove identità e autoregolazione crescono insieme».
Ha immaginato un libro che si rivolgesse a educatori, insegnanti, genitori e bambini. Come è riuscita a tenere insieme pubblici così diversi senza perdere profondità?
«Non dimentichiamo i nonni, presenza fondamentale nella vita dei bambini! Ho voluto creare uno strumento che parlasse a tutti, perché l’inclusione è possibile solo se coinvolge ogni figura educativa. Educatori, insegnanti e genitori trovano nel libro un supporto operativo chiaro e flessibile; i bambini vi si avvicinano invece attraverso il linguaggio diretto delle immagini e dei simboli. La sfida è stata unire semplicità e profondità, evitando tecnicismi ma mantenendo il valore educativo e relazionale. Credo che l’efficacia nasca proprio da questa trasversalità d’uso».
Nel suo lavoro l’accessibilità comunicativa non è un’aggiunta, ma un punto di partenza. Che impatto può avere questo approccio nella scuola e nella società?
«Pensare l’accessibilità come punto di partenza significa creare da subito ambienti in cui tutti possano comunicare, senza dover ricorrere a “soluzioni successive”. È una sfida complessa, spesso sostenuta da insegnanti appassionati che si impegnano per colmare le lacune del sistema. Ma proprio da questi sforzi nascono i veri cambiamenti: servono progettazioni consapevoli e collettive, che riconoscano la ricchezza delle diverse modalità espressive».
Molti adulti faticano a giocare davvero con i bambini, soprattutto in contesti educativi. Che valore ha, secondo lei, il “mettersi in gioco” anche per l’adulto?
«Quando un adulto si mette davvero in gioco, cambia la qualità della relazione: si abbattono barriere, si lascia spazio all’imprevisto e si crea un terreno comune dove il bambino si sente accolto. Il gioco diventa allora un’esperienza condivisa, in cui l’adulto non insegna soltanto ma cammina accanto, con curiosità e apertura. È uno scambio che trasforma entrambi: il bambino si sente riconosciuto, e l’adulto riscopre parti di sé — leggerezza, creatività, meraviglia. È un gesto semplice, ma profondamente educativo».
Nella lunga esperienza in ambito riabilitativo, cosa ha imparato sull’inclusione reale, al di là delle buone intenzioni?
«L’inclusione è un processo che si costruisce insieme, passo dopo passo. Richiede di rallentare, osservare, rispettare i tempi dell’altro. È forse la lezione più grande che ho imparato: non forzare, ma accompagnare. Al Centro Riabilitazione Ferrero ho la fortuna di lavorare con professionisti straordinari: il confronto continuo è ciò che permette di affrontare la complessità di ogni bambino e trasformare difficoltà e frustrazioni in occasioni di crescita condivisa».
Se dovesse immaginare un “sogno lungo” per questo libro, dove le piacerebbe vederlo arrivare?
«Vorrei che diventasse uno strumento diffuso, capace di raggiungere scuole e contesti in cui la comunicazione accessibile è ancora una sfida. Sogno che possa contribuire a un cambiamento culturale: rendere la Caa una pratica naturale, quotidiana, e non un’eccezione. Mi piacerebbe vederlo entrare in realtà educative che hanno voglia di includere, ma spesso si scontrano con difficoltà concrete. Offrire strumenti semplici e chiavi di lettura nuove può davvero fare la differenza».
“La comunicazione va oltre le parole”: cosa può insegnarci, oggi, il linguaggio dei simboli e dei gesti nel nostro modo di relazionarci?
«Viviamo in un tempo in cui le parole scorrono veloci e spesso si perdono tra distrazioni e rumori di fondo. Il linguaggio dei simboli e dei gesti ci riporta all’essenziale: ci invita ad ascoltare davvero e a ristabilire un contatto autentico. I simboli non sono solo segni, ma portatori di significati profondi, capaci di superare barriere linguistiche e cognitive. Ricordano a tutti che la relazione non si fonda solo sulle parole, ma sulla capacità di riconoscere e rispettare l’unicità dell’altro. Ed è lì che nasce la comunicazione autentica, quella che davvero va oltre le parole».

