
NUOVA EDIZIONE Il centenario della nascita di Eugenio Corsini, morto nel 2018, si conclude con la pubblicazione di due libri, La rondine bianca e altri racconti e Come è questo giorno e altro. Poesie 1952-1985, editi da Lindau. I curatori sono, rispettivamente, Valter Boggione e Giovanni Barberi Squarotti, che hanno reso concreto il progetto, sostenuto dalla collaborazione con l’Università di Torino e da una convenzione con San Benedetto Belbo. Il lavoro sarà presentato a breve al centro studi Beppe Fenoglio di Alba e, in primavera, a San Benedetto.
Corsini, nato a Niella Belbo, fu allievo in Seminario di don Natale Bussi, diede la maturità classica da privatista e si laureò in letteratura cristiana antica a Torino con Michele Pellegrino. Dopo alcune esperienze d’insegnamento alle scuole medie e superiori, ottenne la cattedra già appartenuta al suo maestro, alla quale si aggiunse quella di letteratura greca. Il suo ambito di ricerca si concentrò soprattutto sullo studio dell’Apocalisse.
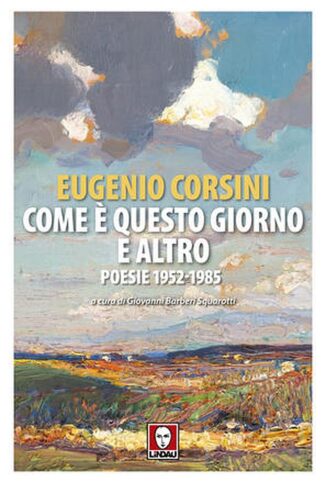 A San Benedetto, Corsini aveva frequentato le elementari; nel 1968 comprò la casa della maestra Luigia Chiavarino. Fu consigliere comunale, presidente della Pro loco, membro della cantoria, promotore del consorzio irriguo del Lago delle Verne, riscopritore della tradizione dei micun.
A San Benedetto, Corsini aveva frequentato le elementari; nel 1968 comprò la casa della maestra Luigia Chiavarino. Fu consigliere comunale, presidente della Pro loco, membro della cantoria, promotore del consorzio irriguo del Lago delle Verne, riscopritore della tradizione dei micun.
L’obiettivo di Boggione e di Barberi Squarotti era di radunare gli scritti di Corsini fuori dalla produzione accademica. Il volume dei racconti, di 376 pagine, include i titoli La straniera, Quello che Dio ha fatto, La morte nel Sole, La disgrazia, Perché l’hanno fatto, La rondine bianca, Alle sorgenti di Belbo e La radice della rosa.
Spiega Boggione: «Pubblicare tutta l’opera letteraria di Corsini era un omaggio doveroso, io e Giovanni siamo stati suoi allievi. Il materiale era disperso, abbiamo lavorato soprattutto nell’archivio di famiglia e della casa editrice Einaudi, la quale ebbe l’intenzione di pubblicare qualcosa. Ci sono degli inediti e dei racconti editi su riviste marginali, come Cronache irpine: lo si deve alla sua frequentazione, a Roma, nell’ambiente della Democrazia cristiana, di Gerardo Bianco. Altri erano apparsi sulla rivista universitaria torinese Sigma. La rondine bianca, edito su Questioni di Mario Lattes, ebbe una certa fortuna. Alcuni scritti possono essere considerati dei romanzi brevi, Corsini ci lavorò per anni e ne fece diverse redazioni».
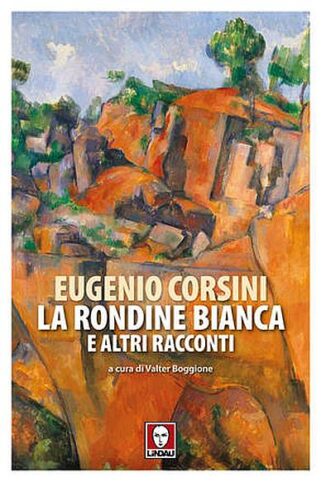 La scrittura del professore langarolo si caratterizza, «soprattutto nei testi giovanili, per una forte presenza di elementi dialettali. Ricerca l’effetto suscitato dalla parola inconsueta o arcaica per descrivere momenti forti e intensamente drammatici, fino a sfiorare l’enfasi. Le storie sono tragiche e forniscono riflessioni su aspetti della vita e sul significato del male. Quelle giovanili si concentrano in gran parte tra San Benedetto e Niella. Vi è pure un’impronta western: in La straniera il protagonista, un piemontese emigrato nella Pampa argentina di ritorno nei luoghi natii, è chiamato il Gringo».
La scrittura del professore langarolo si caratterizza, «soprattutto nei testi giovanili, per una forte presenza di elementi dialettali. Ricerca l’effetto suscitato dalla parola inconsueta o arcaica per descrivere momenti forti e intensamente drammatici, fino a sfiorare l’enfasi. Le storie sono tragiche e forniscono riflessioni su aspetti della vita e sul significato del male. Quelle giovanili si concentrano in gran parte tra San Benedetto e Niella. Vi è pure un’impronta western: in La straniera il protagonista, un piemontese emigrato nella Pampa argentina di ritorno nei luoghi natii, è chiamato il Gringo».
L’arco temporale «è di difficile definizione, le uniche date sono relative ai testi pubblicati. Credo avesse iniziato a scrivere intorno al 1952 e proseguito fino alla metà degli anni Sessanta. Un discorso a parte va fatto per La radice della rosa, più tardo. È la parodia elegante e raffinata de Il nome della rosa di Umberto Eco. Corsini immagina che i personaggi, dopo la distruzione dell’abbazia, finiscano in un monastero delle Langhe, ancora una volta quello di San Benedetto. La visione della vita religiosa e medievale di Corsini è lontanissima da Eco. Resta l’espediente delle notizie ritrovate in un manoscritto». In appendice «ho collocato una relazione sull’esperienza vissuta in Seminario, interessante per capire il contesto».
Per quanto riguarda il volume di poesie, di 144 pagine, Barberi Squarotti aggiunge: «In tutto ci sono circa sessanta liriche. Corsini tende a usare l’endecasillabo in versi liberi. La maggior parte risalgono agli anni Cinquanta e furono pubblicate nel 1962 dall’editore Rebellato. Ce ne sono altre tre apparse nel 1963 su Sigma e, da allora, Corsini tacque come poeta, a parte otto epigrammi composti tra il 1975 e il 1985 su fatti di attualità».
La prima parte «prende spunto anche dalla Resistenza e dalla guerra vissuta da Corsini a San Benedetto. È un’indagine metafisica sui problemi del male piena di riferimenti alla Langa. In questi aspetti, c’è sintonia con Beppe Fenoglio». Per Corsini, «il male penetra nelle terre tramite gli eccidi nazifascisti e le vittime sono i contadini. Partendo dal dato storico, analizza temi biblici come la cattività babilonese di Israele e l’accettazione della disgrazia da parte di Giobbe. Cerca di dare una spiegazione al male, che però, partendo dalla constatazione che non può provenire da Dio, ritiene non abbia soluzione. Occorre quindi accettare la posizione di Giobbe e l’esercizio della pietà per chi soffre. Ricorre, in alcune poesie, anche la critica a una Chiesa che ha tradito la causa».
Davide Barile


