
FAKE NEWS Il progetto didattico-divulgativo “Fake N(Eu)s” è stato ideato da Apice (Associazione per l’incontro delle culture in Europa), realizzato grazie al sostegno della fondazione Crc e con la collaborazione di numerosi partner tra cui Gazzetta d’Alba. Il titolo è riferito al fenomeno delle false notizie, della disinformazione e della loro diffusione nel mondo mediatico. Il 10 gennaio a Cuneo si è tenuto un primo seminario aperto al pubblico. Uno dei relatori era Roberto Moisio, giornalista e autore di “Piccole vedette piemontesi”, un report sull’informazione locale regionale.
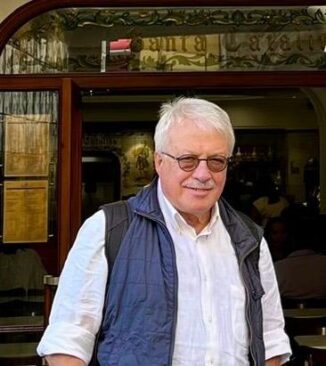
Moisio, perché è importante parlare di fake news?
«Il mondo dell’informazione attraversa un radicale processo trasformativo. Il lettore o l’utente deve destreggiarsi in un ingorgo di fonti frantumate tra social e media tradizionali. La quantità di notizie disponibili è cresciuta in modo esponenziale, così come la loro provenienza. Una volta leggendo la carta stampata era sufficiente confrontare due o tre giornali per crearsi un’idea dell’argomento, oggi diventa impossibile abbracciare la complessità dell’offerta disponibile. Questo per quanto riguarda i grandi giornali e organi mediatici, mentre la stampa locale segue percorsi differenti».
Cosa intende dire?
«La minore diffusione dei grandi giornali rispetto ad alcuni anni fa e la polverizzazione dell’informazione di cui parlavamo prima rendono l’informazione locale l’ultimo presidio in cui è possibile verificare le notizie e la professionalità di chi scrive. Il giornalista in un piccolo centro urbano è conosciuto, lo si può incontrare nei bar e nei locali, quindi è soggetto a una forma di controllo sociale automatico. I fatti di cui parla sono vicini all’esperienza collettiva, chiunque li può verificare attraverso l’azione quotidiana. In questo tipo di contesto diventa più difficile distorcere l’informazione. L’attenzione dei lettori nel caso della stampa locale dovrebbe orientarsi in misura maggiore a “ciò che viene omesso”, perché sono le mancanze e i silenzi il vero pericolo più che l’errore o l’alterazione. Il settimanale locale ha il vantaggio di rimanere per vari giorni in casa, c’è tempo di leggere, rileggere e approfondire. Viene così a crearsi un maggior rapporto di intimità e fiducia con i lettori».
A livello generale, cosa fare dunque per evitare la disinformazione e costruirsi un pensiero critico approfondito e realistico?
«Occorre dedicare tempo, incrociare le fonti, allenare l’attenzione e la possibilità di costruire un pensiero personale, poco condizionato da stereotipi o manipolazioni esterne. In linea generale è anche importante che i colleghi giornalisti vengano adeguatamente pagati per il proprio lavoro. Conosco delle situazioni in cui i professionisti non guadagnano neanche dieci euro per un articolo scritto. Questa forma di sottoretribuzione incide in maniera importante sulla qualità del prodotto finale. Infine, per garantire un buon livello dell’informazione e della sua fruizione è importante agire sul mondo scolastico, impostare percorsi formativi che allenino lo spirito critico e la solidarietà. Pensiamo alle televisioni, alle immagini di guerra che scorrono ogni giorno. Sovente i nostri meccanismi di difesa dal dolore ci impediscono di “empatizzare” in maniera sufficiente, costringono a distogliere l’attenzione dalle bombe cadute o dai corpi delle vittime. In parte questa modalità di “isolamento affettivo” è funzionale a “non soffrire troppo”, ma non possiamo utilizzarla sempre, altrimenti perdiamo il senso della realtà fino a diventare insensibili alle sofferenze delle altre persone».
Valerio Re

